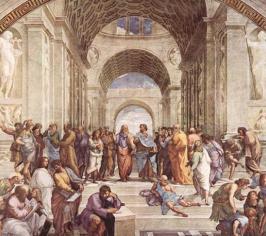L’età umanistica inizia nel 1400 e finisce nel 1492, quella rinascimentale comincia nel 1493 e finisce nel 1559.
Con l’Umanesimo vi è un cambiamento di mentalità rispetto al Medioevo antecedente al 1400. Questo cambiamento veniva già anticipato da Petrarca e Boccaccio e consiste nel vedere l’uomo al centro. È quindi una visione antropocentrica (in greco anthropos significa uomo) e non più teocentrica come era nell’età medievale.
Boccaccio anticipa questo antropocentrismo nel suo Decameron, quando pone al centro l’uomo, le sue capacità, la sua intelligenza e la capacità di tirarsi fuori da situazione problematiche.
Prima l’uomo era visto come una creatura fragile, contaminata dal peccato originale, nell’età umanistica, invece, si ha una visione ottimistica dell’uomo, visto sicuro, pieno di forze, capace di contrattaccare i colpi della ‘Fortuna’ con la propria energia e la propria intelligenza e di crearsi da solo il proprio destino.
Viene esaltata la dignità dell’uomo. Non ci si allontana in maniera radicale dalla religione, che rimane importante, ma si rivendica il valore autonomo della realtà: l’esistenza terrena non è finalizzata al conseguirsi della vita eterna (dopo il trapasso) ma ha un valore autonomo.
La vita è dovuta e va goduta senza sensi di colpa. Questi aspetti, gli umanisti e rinascimentali, li ritrovano anche nei classici, che vengono quindi sempre considerati dei modelli. Si riscopre la civiltà antica e si condanna il Medioevo, che viene rivisto come un periodo scuro, di degrado. Da qui deriva proprio l’idea della rinascita (da qui la parola Rinascimento) della civiltà greco-romana.
I classici diventano esempi da imitare, si afferma quindi il principio di imitazione. Si riprende la filosofia di Platone, la scrittura di Cicerone, si torna a studiare il greco (già Petrarca e Boccaccio studiavano la lingua greca). Inizia una ricerca di manoscritti nelle biblioteche, per riportare alla luce i testi antichi e ripulirli dagli errori: nasce la filologia.
Il termine ‘Umanesimo’ deriva da studia humanitatis (studi di umanità), ovvero gli studi delle lettere.
Gli studi delle lettere vengono ritenuti indispensabili per lo sviluppo armonioso dell’individuo, per la sua formazione.
Nel ‘400, data questa riscoperta della cultura classica e del latino, in particolar modo nella prima metà del secolo, si riprende ad usare il latino. Successivamente si passa di nuovo all’uso del volgare, utilizzato però con i criteri di stile degli autori classici.
Un’opera che fa da manifesto dell’età umanistica, esaltando l’uomo e la sua dignità mettendolo al centro dell’universo, è rappresentata dal De hominis dignitate di Giovanni Pico della Mirandola.
Costui è noto per la sua proverbiale memoria. Era un nobile appartenente alla famiglia principesca dei Pico, conti della Mirandola (vicino a Modena).
Il De hominis dignitate (“La dignità dell’uomo”) è l’introduzione a uno dei suoi trattati. In questo scritto Giovanni narra che l’uomo fu creato da Dio (la religione non è quindi ignorata) per ultimo, “come attestano Mosè e Timeo” (riferimento alla filosofia di Platone), dopo aver creato tutto il ‘creato’ così da poter avere una creatura che potesse capire la sua opera. L’uomo viene generato in modo che sia una creatura indefinita, di libero arbitrio, che si possa determinare da solo il proprio destino.
Estratto dal “de hominis dignitate”:
...La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai.
La seconda metà dell’età umanistica è caratterizzata dall’utilizzo della lingua volgare.
Un esempio di testo in volgare è dato da Il trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici.
Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico, fu Signore di Firenze dall’età di vent’anni fino alla morte, avvenuta nel 1492, anno della scoperta dell’America e inizio di guerre contro la penisola italica: con la sua morte finisce l’equilibrio da lui sino ad allora mantenuto.
Oltre che politico, è anche scrittore, sua opera famosa è appunto il Canto carnascialesco (cioè scritto per il Carnevale) ‘Trionfo di Bacco e Arianna’.
Estratto dal canto carnascialesco “Trionfo di Bacco e Arianna”:
...Quest’è Bacco e Arianna,
belli, e l’un dell’altro ardenti:
perché ‘l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Qui si riscontra il principio del Carpe Diem (‘afferra il giorno’, ‘cogli l’attimo’), in una valorizzazione del vivere: saper cogliere il piacer del vivere. Bisogna cogliere l’attimo poiché il tempo fugge e inganna.
La seconda metà del ‘400 vede anche il trionfo del poema epico-cavalleresco. Uno dei primi esempi dell’uso della lingua volgare in un poema epico è rappresentato dalla Chanson de Roland, dove si parla della figura di Orlando, paladino di Carlo Magno, e della sua guerra contro i Saraceni.
Questa è una tematica che viene coltivata e riproposta attraverso i ‘cantari cavallereschi’, componimenti narrativi in versi che trattano la materia cavalleresca carolingia o bretone. Questi vengono recitati nelle piazze dai giullari e sono molto apprezzati dal pubblico poiché comprendono l’epica, la guerra ma anche il magico, il meraviglioso, l’amore e il fantastico, il tutto enfatizzato dalla comicità dei giullari.
Vi sono degli autori che ripropongono questa materia in chiave colta, scrivendo opere di alto livello. Il primo a fare questo è Matteo Maria Boiardo, un conte nato vicino a Reggio Emilia.
Scrive il suo capolavoro l’ Orlando innamorato a Ferrara, essendo amico e frequentatore dei duchi d’Este.
La vicenda dell’Orlando innamorato si svolge nel seguente modo. Nel Forte di Carlo Magno si sta celebrando un sontuoso banchetto, a un certo punto compare Angelica, figlia del re del Cataio (la Cina), che ammalia con la sua sfolgorante bellezza tutti i presenti, che la inseguiranno cercando di ottenere il suo amore. In particolar modo Orlando perderà per lei addirittura la ragione, fino a sfidare il paladino Rinaldo, anch’esso innamorate di Angelica. Boiardo finisce l’opera con re Carlo che separa i due sfidanti e promette la principessa a quello dei due che combatterà più valorosamente nella battaglia contro i Saraceni. La vicenda verrà successivamente continuata da Ariosto nel suo Orlando furioso dove si vede che Orlando arriva alla pazzia.
Boiardo, col suo Orlando che cade in preda all’amore, porta a compimento la fusione dei due cicli cavallereschi, il carolingio e l’ arturiano, già avviata nei secoli precedenti.
La ‘prodezza’ cavalleresca non è più solo forza guerriera, ma è la ‘virtù’ dell’individuo libero, attivo, energico, che sa superare ogni ostacolo e che, come anticipa Boccaccio, sa vincere la Fortuna.
Amore e armi, formando un’inscindibile unità, esprimono una visione rinascimentale della vita, in senso laico, mondano, edonistico. La più vicina incarnazione di questa visione dell’amore è rappresentata da Angelica, che è completamente diversa dalle donne angelo dello Stil Novo e anche dalla Laura petrarchesca. È una donna seducente e tenera, sensuale e capricciosa, crudele e appassionata, protesa con tutte le forze a soddisfare il suo desiderio amoroso, facendo perdere la testa ai cavalieri, sviandoli dai loro doveri.
Estratto dal Proemio de l’Orlando innamorato:
...«Ahi paccio Orlando!» nel suo cor dicia
«Come te lasci a voglia trasportare!
Non vedi tu lo error che te desvia,
e tanto contra a Dio te fa fallare.
Dove mi mena la fortuna mia?
Vedome preso e non mi posso aiutare;
io, che stimavo tutto il mondo nulla,
senza arme vinto son da una fanciulla.
Esempio di intellettuale cortigiano del Rinascimento è rappresentato da Ludovico Ariosto.
Il poeta proveniva da una nobile famiglia, il padre Nicolò era funzionario al servizio dei duchi d’Este di Ferrara e comandate della guarnigione militare di Reggio Emilia. In questa città nacque Ludovico l’8 settembre del 1474, il primo di dieci tra fratelli e sorelle. In seguito viene impiegato anch’esso al servizio dei duchi d’Este, innanzi tutto presso il cardinale Ippolito d’Este, figlio del duca Ercole I, per il quale fa missioni politiche e diplomatiche e successivamente per il duca Alfonso.
Nel 1516 pubblica la prima edizione dell’Orlando furioso e la dedica al cardinale Ippolito. Nel proemio descrive il fatto che non viene retribuito come vorrebbe dal cardinale, che ha scarsa considerazione per la poesia. Qui si nota come un individuo così interiormente libero si pone rispetto al suo signore in un epoca come questa.
Come già accennato Ariosto passa poi a lavorare per il duca Alfonso che gli dà anche incarichi importanti. Nel 1522 gli affida il compito di governatore della Garfagnana, regione appenninica da poco annessa al Ducato estense di difficile gestione; nonostante la sua preferenza per il lavoro intellettuale si dimostra un bravo amministratore. Accusando però la lontananza dalla sua città, provato dalle tante incombenze pratiche, decide di tornare a Ferrara e dedicarsi alla poesia e agli studi.
Mentre lavora per il duca Alfonso si innamora, inoltre, di Alessandra Benucci, donna sposata che dopo essere diventata vedova si sposerà in segreto con Ariosto; anche lei è nominata nel Proemio dell’Orlando furioso.
Nel periodo della vecchiaia riuscirà poi a ritirarsi in una casa appartata dove potrà dedicarsi esclusivamente ai suoi scritti (Otium letterario).
L’Orlando furioso di Ariosto riparte da dove era finito l’Orlando innamorato di Boiardo.
Alla vigilia della Battaglia tra i Mori che assediano Parigi e i cristiani, Carlo Magno affida Angelica a Namo di Baviera, per evitare la contesa tra Orlando e Rinaldo che ne sono entrambi innamorati, promettendola a chi si dimostrerà più valoroso in battaglia. I cristiani sono messi in rotta, e Angelica ne approfitta per scappare. Viene inizialmente inseguita da Rinaldo e Ferraù e successivamente anche da Orlando.
Questa è una trama complessa scritta per suscitare interesse. L’autore porta avanti il racconto di più vicende contemporaneamente, troncandole e riprendendole, conducendo numerosi fili narrativi per introdurre sempre una novità e risultare interessante.
L’opera ha il fine di intrattenere cortigiani e persone colte.
Si individuano tre filoni: la guerra del re britanno Agramante a Carlo Magno sul suolo di Francia, l’amore di Orlando per Angelica (argomento centrale) e la vana ricerca della donna amata con la scoperta del tradimento (ella si sposerà con Medoro), la follia di Orlando e il suo risanamento grazie ad Astolfo che recupera il suo senno con un viaggio con un ippogrifo sulla luna e le vicende di Ruggiero (pagano) e Bradamante (cristiana), che alla fine riusciranno a sposarsi. Ruggiero si converte al cristianesimo e insieme a Bradamante danno origine alla casa estense: in questo modo Ariosto dà agli Este un origine nobilissima.
Un’opera tale da suscitare intrattenimento e suscitare sorpresa in realtà è un opera che vuole rappresentare la realtà nella sua complessità. Uno dei motivi centrali dell’opera è quello dell’inchiesta, cioè la ricerca di un oggetto di desiderio (es.: Angelica, un elmo, un cavallo). Ma mentre nei romanzi arturiani medievali la queste si caricava ai sensi mistico-religiosi (soprattutto la ricerca del Santo Graal), nell’Orlando furioso l’inchiesta assume un carattere del tutto profano e laico. Questa è una ricerca inappagata che si può trasformare in follia (es.:Orlando folle di amore, Bradamante folle di gelosia, Rodomonte folle di dolore).
Si può dedurre che i valori cavallereschi non vengono più riproposti come possibili nella civiltà cortigiana del ‘400, ‘500, che ormai è molto diversa. Sono però presi come argomenti di narrazione perché possono dare agito a una riflessione, su argomenti come la molteplicità e la mobilità del reale, il capriccio della fortuna, la ricerca vana dell’oggetto del desiderio che sempre sfugge, l’aspetto ingannevole della realtà. Ariosto fa riflettere sul fatto che proprio i personaggi che rimangono più fedeli ai loro principi e ideali possono arrivare, in questa loro rigidità, alla pazzia; come Orlando che per amore di Angelica arriva alla pazzia e non è capace di consolarsi con qualcos’altro. Questa idealizzazione può diventare sostanzialmente pericolosa.
Di contro Ariosto introduce personaggi più spregiudicati e pragmatici, che riescono ad adattarsi più facilmente alla mutevolezza della realtà. Ad esempio Ferraù sa rinunciare ad Angelica e si accontenta di un oggetto meno sublime, l’elmo di Orlando. Mandricardo, incontrata Doralice, dimentica subito la sua inchiesta eroica di Orlando, con cui vuole misurarsi, e si accontenta di godere delle grazie della donna.
Al contrario quindi di altri personaggi più pragmatici, Orlando non si accontenta di qualcos’altro e quindi arriva a perdere il senno.
Estratto dal Canto XXIV de l’Orlando furioso:
Chi mette il piè su l’amorosa pania,
cerchi ritrarlo, e non v’insechi l’ale,
che non è in somma amor, se non insania,
a giudizio de’ savi universale:
e se ben come Orlando ognun non smania,
suo furor mostra a qualch’altro segnale.
E quale è di pazzia segno più espresso
che, per altri voler, perder se stesso?
In questi versi Ariosto esprime che se una persona non vuole un’altra è una causa persa andare avanti poiché sarebbe un tormento continuo e di conseguenza porterebbe alla pazzia.